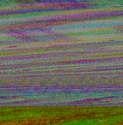Come erano le case dei nostri antenati contadini, artigiani e lavoratori di campagna? Ma soprattutto come si svolgeva una loro giornata lavorativa? E’ interessante conoscere anche come si procuravano il fabbisogno necessario per mangiare, vestire e scaldarsi?
Tutte queste domande ed altre ancora possono essere soddisfatte visitando le principali esposizioni di alcune persone che amano custodire gelosamente le usanze del passato o meglio visitando qualche museo della civiltà contadina, i quali offrono la possibilità di rispondere, assieme ad altre più specifiche, relative alla terra, agli alberi, alle piante e agli animali, che sono stati oggetto di cure quotidiane dei nostri contadini ed artigiani.
Domande che riguardano non solo il passato ma anche il presente della nostra economia e della nostra società: che cos’è una fibra tessile, come si pastorizzava il latte, come si faceva il formaggio, lo zucchero e che si faceva con le mele ed altri tipi di frutta.
Insomma è giusto fare un bel viaggio nella memoria contadina per scoprire la bellezza delle arti e tradizioni popolari.
Le tradizioni culinarie della Capitanata non possono prescindere dalla festa del Natale che riconda momenti intensi, legati a tempi sempre più lontani.
Descrivere sensazioni, atmosfere e ricordi si rivivono Natali realmente trascorsi, facendo un balzo indietro nel tempo.
I scarpèlle
Ecco invece la nostra tradizione. Il pomeriggio della vigilia di Natale si impastava la farina con acqua tiepida, lievito e un po’ di sale e si lasciava lievitare per alcune ore. Verso sera si tagliavano dei pezzetti di pasta che venivano lavorati con le mani bagnate per allungarli fino a 20 – 25 cm, quindi si friggevano con olio bollente. Si servivano calde mano a mano che erano pronte. Quelle che avanzavano, si consumavano nei giorni successivi e si mangiavano a colazione o a cena, riscaldate alla brace del camino o del braciere….
Nèvel’e kavezune.
Le nonne e le mamme impastavano sulla spianatoia la farina con le uova, lo zucchero, l’olio e il vino bianco. Mescolavano bene il tutto e lavoravano la pasta fino a renderla liscia e morbida. Facevano delle sfoglie sottili e le tagliavano a strisce di cm 2 circa con una rotellina dentata. I bordi di ogni striscia venivano uniti con le dita a intervalli regolari.
Questi nastri di pasta alla fine assumevano la forma di una rosa. Ottenuti, così, i nèvele, si friggevano con olio bollente. Sistemati in un vassoio le nonne le condivano con il mostocotto o con il miele.

Per preparare i kavezune si usava la stessa pasta di nèvele Era tenuta a sfoglia e tagliata a quadretti. Al centro di ogni quadretto si poneva un po’ d’impasto fatto di ceci lessati, ridotti a purè e conditi con zucchero, cannella e mosto cotto. Erano i kavezune ki cice.
I quadretti di pasta potevano essere farciti anche con un impasto di mandorle tostate, zucchero e mosto cotto oppure ka mustarde, marmellata di uva. erano chiusi come panzerotti e rifiniti con la solita rotella dentata. Si friggevano in olio bollente.
A kruccande
Nelle festività natalizie non poteva mancare a kruccande, un impasto di mandorle e zucchero.
Le mandorle sgusciate si sbollentavano per alcuni minuti, si spellavano e si tagliavano a pezzetti sottilissimi, versati in un tegame.
Si univa lo zucchero e si faceva cuocere a fuoco lento, mescolando continuamente. Ogni tanto si aggiungeva un po’ di succo di limone per non far attaccare.
Quando lo zucchero diventava color caramello e il composto si staccava dalla parete del tegame, si toglieva dal fuoco, si versava su un marmo bagnato e si stendeva con un matterello. Si tagliavano delle strisce e da esse dei rombi che si allineavano su un vassoio.
Si tagliavano delle strisce e da esse dei rombi che si allineavano su un vassoio.
U purcèll’e u rraù a Tarranòve.
Tanti anni fa nel mese di settembre alcune famiglie di Poggio Imperiale, come del resto avveniva in molti Comuni della Capitanata, si recavano alla fiera di un paese vicino per comprare u purcélle, il lattonzolo, che veniva allevato in casa. (Il maiale ingrassa presto, perciò, nel giro di tre o quattro mesi poteva essere ammazzato).
Grandi e piccini erano impazienti (e come si dice da noi: ne vedévene l’óre de ccíd’u pórce) per gustare carne arrostita alla brace e preparare i vari salumi, il lardo e la saíme (la sugna) da consumare durante il Carnevale o nelle grandi occasioni.
Agli inizi di dicembre a Poggio Imperiale si cominciava a fare il conto alla rovescia, facendo il riferimento ad alcune feste:
I sèje jè Sande Nekòle,
a li jòtt’a Mmakulata Cungèzióne,
i vindicinke nasce u Rèdèndóre,
i vindisèje ce ccid’u pórce sènza delóre.
Perché la tradizione voleva che il maiale si ammazzasse subito dopo Natale o durante i primi giorni di gennaio.
Il giorno di festa, specialmente la domenica, era dedicato a u rraú, il ragú. La parola è un adattamento del termine francese ragoút, che rispecchia la sua effettiva pronuncia. Questa parola, deverbale di ragoúter da goút, gusto (risvegliare il gusto, l’appetito) è una deformazione del dialetto napoletano, quando sotto il regno di Ferdinando IV di Borbone vi fu una grande influenza della cultura e delle mode francesi nella corte del Regno di Napoli.
Per ragú s’intende quel delizioso sugo di carne trita e salsa (o concentrato) di pomodoro che si ottiene lasciando gli ingredienti a cottura, su un fuoco lento, per molte ore per rinnovare il gusto e dare più sapore.
Dalla tradizione francese il ragoút divenne il sugo di carne italiano per eccellenza, ospite d’onore nei banchetti delle famiglie ricche, ma talvolta presente anche sulla tavola delle famiglie povere che utilizzavano il metodo della cottura lenta per estrarre ogni possibile traccia di sapore anche dai più scarsi avanzi di carne.
Per estensione il termine è quasi sempre usato impropriamente come sinonimo generico di sugo soprattutto nel sud Italia, dove è fatto con pezzi interi di carne, chiamati brajòle.
Le braciole sono dei grossi involtini di carne di vitello, conditi con lardo, aglio, formaggio, prezzemolo, sale e pepe (o in alternativa peperoncino), che vengono chiusi con lo spago da cucina, oggi anche con degli stuzzicadenti.
Si tagliava a pezzettini un po’ di lardo e si faceva sciogliere sul fuoco e subito dopo si faceva rosolare prima la cipolla e poi la carne innaffiata con un goccio di vino bianco. In alternativa al lardo si usava a saíme, il grasso del maiale da cui si ricavano lo strutto da cucina e altri grassi. Si aggiungeva un cucchiaio di conserva.
 Bastava, infatti, solo un cucchiaio, si rimestava, si versava un po’ d’acqua, si faceva cuocere a fuoco lento per due ore circa.
Bastava, infatti, solo un cucchiaio, si rimestava, si versava un po’ d’acqua, si faceva cuocere a fuoco lento per due ore circa.
Anche per la preparazione da cunzèrve erano necessari una certa competenza e un rituale particolare. Si raccoglievano i pomodori, si lavavano, si cuocevano e si passavano al setaccio. Il succo ottenuto si versava nei piatti di terraglia molto decorati che si allineavano sui tavoli posti davanti alle proprie abitazioni in una posizione soleggiata. Con un cucchiaio di legno si girava rigirava il succo e mano a mano che diventava più denso, il contenuto di più piatti si versava in un solo piatto. Quando era abbastanza ristretto si versava in un vasetto cilindrico e si copriva con l’olio. Bastava quindi un solo cucchiaio ogni volta che le nonne dovevano preparare l’ottimo rraú per condire la pasta.
 La pasta, di solito i zite, già lessata, era condita con questo rraú e con pecorino a piacere.
La pasta, di solito i zite, già lessata, era condita con questo rraú e con pecorino a piacere.
La pasta si faceva in casa e naturalmente veniva condita con u rraù (il ragù). Si preparavano, come del resto si fa ancora in alcune famiglie, i recchjtèlle (orecchiette), i ‘ndòrcele (i troccoli), i lajene (fettuccine, tagliatelle), i cekatélle (i cavatelli).
I recchjetèlle  S’impasta la farina, si assottiglia la pasta e si tagliano dei pezzi lunghi come grissini, si stacca di volta in volta un pezzettino e si fanno i recchjetèlle con la punta del coltello, accompagnando con il pollice.
S’impasta la farina, si assottiglia la pasta e si tagliano dei pezzi lunghi come grissini, si stacca di volta in volta un pezzettino e si fanno i recchjetèlle con la punta del coltello, accompagnando con il pollice.
Cekatélle  La pasta non si assottiglia molto. si tagliano dei pezzi di 2 – 3 cm, si preme su ciascuno di essi con l’indice e il medio.
La pasta non si assottiglia molto. si tagliano dei pezzi di 2 – 3 cm, si preme su ciascuno di essi con l’indice e il medio.
I lajene  Per questo tipo di pasta la sfoglia deve essere molto sottile. Si formano dei rettangoli che si arrotolano. Uno alla volta si tagliano come dei rotolini di stelle filanti, si srotolano e si cospargono con un po’ di farina per farli asciugare.
Per questo tipo di pasta la sfoglia deve essere molto sottile. Si formano dei rettangoli che si arrotolano. Uno alla volta si tagliano come dei rotolini di stelle filanti, si srotolano e si cospargono con un po’ di farina per farli asciugare.
I ‘ndòrcele  Con la pasta si forma una sfoglia non molto sottile, quindi si passa u ‘ndòrcele, uno strumento di legno con delle scanalature, che taglia la pasta riducendola in spaghetti molto spessi.
Con la pasta si forma una sfoglia non molto sottile, quindi si passa u ‘ndòrcele, uno strumento di legno con delle scanalature, che taglia la pasta riducendola in spaghetti molto spessi.
Preparazione del pane e della pizza
Il pane si preparava in casa, ce ‘mmassàve (s’impastava). Si preparava la farina ‘ndà fazzatore per separarla dalla crusca e si aspettavano le due o le tre del mattino per impastare. A fare la levataccia era generalmente la padrona di casa, ma quando in famiglia c’erano figlie femmine già grandi, erano queste ultime ad occuparsene, anche se la mamma dirigeva i lavori.
Non era raro il caso, però, che, in assenza di altre donne in famiglia, per aiutare la mamma, si svegliassero e si alzassero dal letto anche i figli maschi, specialmente i più piccoli che dovevano andare a scuola e non al lavoro. Anche in questo caso era sempre la mamma ad iniziare i lavori e solo successivamente intervenivano i figli che continuavano ad amalgamare la pasta fino a quando non diventava uniforme e cacciava le bollicine.
Era tutto un lavoro di braccia.
Diventata uniforme, la pasta veniva coperta con strofinacci e coperte e si lasciava lievitare per alcune ore. Dopo questo lavoro, le operaie della pasta, mamma e figli, ritornavano nuovamente a letto per risvegliarsi alle sei o sette del giorno, quando la pasta doveva essere scoperta e tagliata ( ce sckanàva), si faceva qualche altra manipolazione e poi si metteva in cesti di vimini, preventivamente preparati con apposite pezzature e coperti con un tovagliolo (a mappìne) cosparso di farina per non far attacare la pasta.
Chi aveva un cortile (u ‘ssétte) con il forno, cuoceva il pane in casa.
Generalmente, quando si panificava, si preparava anche la pizza con pomodoro, sale e olio o anche senza niente. Questo tipo di pizza era chiamato pizze ‘n dèrre (pizza a terra), condita, per chi lo aveva, ku meste kotte (mostocotto).
 Questa pizza, uno dei migliori dolci della cucina abruzzese, è stata portata in Puglia e specialmente in Capitanata dai pastori abruzzesi che giungevano in queste contrade insieme con le greggi.
Questa pizza, uno dei migliori dolci della cucina abruzzese, è stata portata in Puglia e specialmente in Capitanata dai pastori abruzzesi che giungevano in queste contrade insieme con le greggi.  Ora è quasi del tutto estinta. Se ne conserva l’uso solo in poche famiglie di contadini.
Ora è quasi del tutto estinta. Se ne conserva l’uso solo in poche famiglie di contadini.
Quando si macinava il grano, si ricavava u russetélle, il prodotto della macinazione prima della farina e dopo della crusca. Con esso si facevano focacce semplici, ma gustose (pizze d’ russetélle).
Era presente spesso a tavola a pizze de ranedinje. La pasta s’impastava con la farina di mais e la pizza si condiva con un filo, un po’ di sale e rosmarino. Altra specialità era a pizz’abbuttate. Sistendeva la pasta del pane e, senza condimento, s’infornava quando nel forno ancora non si consumava la fiamma. (Questo tipo di pizza era detto anche pizz’a la vambe). La pasta con il calore si gonfiava. Quando aveva preso colore si sfornava, si tagliava in due parti e s’inbottiva con la ricotta. I bambini la mangiavano così in fretta che è rimasto il detto: pare pizz’a la vambe, per dire di qualcosa che finisce subito.
Altra specialità era a pizz’abbuttate. Sistendeva la pasta del pane e, senza condimento, s’infornava quando nel forno ancora non si consumava la fiamma. (Questo tipo di pizza era detto anche pizz’a la vambe). La pasta con il calore si gonfiava. Quando aveva preso colore si sfornava, si tagliava in due parti e s’inbottiva con la ricotta. I bambini la mangiavano così in fretta che è rimasto il detto: pare pizz’a la vambe, per dire di qualcosa che finisce subito.
Non poteva mancare sulla tavola dei nonni a pizze ki sfringele (pizza con i ciccioli).Questa pizza veniva preparata solo quando si ammazzava il maiale. I ciccioli erano i pezzettini di carne che rimanevano quando si faceva scigliere la sugna. Essa era conservata in vasetti di creta oppure ndà sammécchje (budella di maiale).  Si spalmava a saìme (la sugna) sulla sfoglia già preparata e si versavano i ciccioli.Il rotolo preparato si schiacciava fino a dare la forma della pizza, poi si ungeva ancora un po’ di sugna e si infornava. Questa pizza era molto appetitosa, ma non di facile digestione. Queste pizze, specialmente se ben condite, saziavano, perciò sostituivano il pranzo.
Si spalmava a saìme (la sugna) sulla sfoglia già preparata e si versavano i ciccioli.Il rotolo preparato si schiacciava fino a dare la forma della pizza, poi si ungeva ancora un po’ di sugna e si infornava. Questa pizza era molto appetitosa, ma non di facile digestione. Queste pizze, specialmente se ben condite, saziavano, perciò sostituivano il pranzo.
Le credenze popolari
La tradizione popolare vuole che nella notte fra il 1 e il 2 novembre i morti ritornano sulla terra.
Si recano prima in Chiesa ad assistere alla celebrazione della S. Messa e dopo la funzione religiosa, ciascuno, stanco del viaggio, ritorna alla propria casa per riposare. Ecco perché esiste la credenza che erano le anime dei morti che il 2 novembre portavano i doni ai bambini.
Nel nostro paese era vivissima anche la credenza che si potesse effettivamente vedere la processione delle anime che arrivavano.
I nonni, infatti, raccontavano che per primi c’erano i morti di morte naturale: davanti a tutti i bambini, le fanciulle, donne e uomini che cantavano, poi i condannati, i morti per disgrazia, i morti improvvisamente… ed infine gli zoppi, gli storpi e così via…
In tale data si crede che i morti riprendano il corpo, visitino i luoghi in cui sono vissuti e segnino con una croce, invisibile ai vivi, l’abitazione delle persone che dovranno morire durante l’anno.
E’ opportuno, pertanto, prima di andare a letto, lasciare la casa in ordine per evitare che i morti inciampino e apparecchiare la tavola con pane, acqua e coltello per offrire loro da mangiare e da bere.
Anche ai cavalli, agli asini e ai muli, una volta, si dava, nella stessa notte, una maggiore quantità di paglia e di avena.
Qualche persona anziana racconta di aver visto la processione dei morti che di notte si snodava lungo le vie del paese per raggiungere una chiesa dove assistere alla celebrazione della Santa Messa.
Ad evidenziare la realtà dell’evento si racconta che la signora Maria Carmela Palmieri in Rendina (1860-1942), la notte dell’Epifania, avendo sentito suonare le campane della chiesa della Madonna delle Grazie, si preparò per andare a messa. Trovò la chiesa gremita di persone che partecipavano al Sacro Rito e queste persone la guardavano meravigliate. Una di loro la invitò ad uscire chiudendole la porta in faccia, mentre un lembo della sua tunacèdda (vestito lungo) rimaneva impigliata. Recuperatolo a fatica, la donna tornò a casa ancora frastornata e andò a dormire. Quando si svegliò, pensò di aver fatto un sogno, ma l’orlo della sua tunacèdda, ancora bagnato, le rivelò la sua reale partecipazione ad un evento straordinario.
Poteva assistere a questa manifestazione notturna solo chi accendeva uno stoppino preparato con il cerume prelevato dalle orecchie durante l’intero anno.
La stessa credenza è presente anche a Sannicandro Garganico, ma la processione dei morti può essere vista la sera del 1° novembre da coloro che accendono una candela preparata con il cerume prelevato nell’arco dell’anno.
Le anime dei morti, secondo quanto dice Isabella Gualano, sfilano in maniera ordinata e gerarchica. Anche a Sannicandro si usa apparecchiare la tavola con ogni ben di Dio per far cibare eventualmente i morti. I bambini appendono dietro la porta la calza per avere dolci e leccornie se sono stati buoni, cenere e carboni se sono stati cattivi.
A Poggio Imperiale i nonni raccontavano che agli inizi del 1900 il sacerdote don Raffaele Ricciardi, verso la mezzanotte, non curandosi dell’ora tarda, stava ancora completando la lettura del suo breviario, quando, all’improvviso, sentì per la strada un canto celestiale. Incuriosito, si affacciò appena dietro la finestra e vide una lunghissima processione.
 Davanti a tutti c’erano bambini vestiti di bianco, poi seguivano uomini e donne vestiti i primi di un colore, altri di un altro colore, altri ancora di colore diverso e così via… (i colori dei vestiti stavano ad indicare il tipo di morte che avevano subito). Chiudeva questa lunghissima processione una schiera di persone zoppe, mutilate oppure aventi altri mali fisici.
Davanti a tutti c’erano bambini vestiti di bianco, poi seguivano uomini e donne vestiti i primi di un colore, altri di un altro colore, altri ancora di colore diverso e così via… (i colori dei vestiti stavano ad indicare il tipo di morte che avevano subito). Chiudeva questa lunghissima processione una schiera di persone zoppe, mutilate oppure aventi altri mali fisici.
All’improvviso la processione si fermò e una figura vestita di bianco fece un segno di croce vicino ad una porta. Il prete rimase fermo e attonito… La processione continuò per la sua strada e pian piano si allontanò dalla vista del sacerdote. Ancora attonito, fece il segno di croce ed andò a letto.
La mattina seguente, appena sveglio, com’era solito fare, si affacciò alla finestra e vide all’angolo della strada, vicino alla porta dove era stata segnata una croce la notte precedente, un gruppo di persone agitate ed altre che piangevano. Incuriosito, chiese notizie ed apprese che in quella casa era morta una signora. Si ritirò in casa e collegò l’accaduto a quello che aveva visto la notte precedente.
Qui di seguito sono riportati alcuni oggetti che ci riportano al passato.
Questi oggetti e tanti altri ancora non inseriti in questa pagina, sono stati raccolti e selezionati da Leonardo Iadarola di Poggio Imperiale.
Leonardo (Nardine), appassionato esperto, con pazienza sta promuovendo e realizzando l’allestimento, in un capannone di sua proprietà, di una raccolta di attrezzi e masserizie del secolo scorso per ricordare e far rivivere la nostra civiltà contadina
Nei pressi del fuoco, solitamente era sospeso un lungo pezzo di legno, dove, secondo le stagioni, venivano appesi soprressata, il lardo, la salsiccia, la vescica di maiale riempita di saìm’e sausicchje (sugna e salsiccia), i diavelicchje (piccoli peperoni piccanti), ‘nsèrte di pomodori, di fichi…
E’ importante che le collane siano al caldo, in luoghi con bassa umidità per evitare di sviluppare muffe e siano al riparo dal sole diretto.